|
la
scena.
un tavolino con
sopra un mappamondo. dal soffitto scende un filo da pesca al quale è
appeso un cappello anni 30, a circa due metri daltezza. un abat-jour e
un leggio.
dal buio, si accende la luce.
la regione
abitata e deserta
la regione sommersa
la regione del canto
la regione della bestia.
levidenza dei
corpi sparsi non è una evidenza, ma qualcosa come lalone del rossetto o
le ditate sullo specchio del bagno, che saltano fuori nel vapore della
doccia bollente.
levidenza dellarchitettura casuale di ciò che non ho avuto, di ciò che
non ho saputo, di ciò che non sono stato, utopie sepolte, il ricordare
amaro. come quella volta che, comprando un brutto libro da regalare ad
un natale, la pelle mi si è messa a sudare. come quel primo maggio,
ventanni prima, a san sebastian, donostia. o tipo la pietra infame che
rompe alla vanga il filo, quelle vertebre preistoriche di dinosauro con
sopra i numerini messe dentro scatole di legno con i numerini e qui ci
vuole un bel disegno, un bel immaginarlo lì a brucare, grande come un
transatlantico, nel campo di periferia, tra le lavatrici buttate,
poltrone sfondate, materassi e goldoni, gatti morti.
la strada per bassora è una linea kilometrica di camion e carri
distrutti, bruciati. si capisce dai denti che era un soldato, un uomo.
dai denti, perché restano bianchi e distinti sullo sfondo nerobruno
carbonizzato.
io vorrei sentire
un po meglio, ma il rilievo dei corpi sparsi è in fondo modesto. |
il
futuro ha divorato il mio bambino.
eravamo eredi di
parole che non volevamo più sentire.
eravamo attori di palchi che non volevamo più calcare.
eravamo figli della strada non segnata.
padri e madri della terra più arsa.
fratelli di ognuno che fosse ribelle per odio, fame o gioco.
sorelle delle voci più pure delle lingue più roche.
il mio bambino oggi sarebbe il bambino dei miei figli e giocherebbe con loro.
ho perso il mio bambino: venduto al ricco turista, rapito,
lo hanno chiuso in collegio, nel carcere, nella corsia di un pronto soccorso.
il mio bambino è diventato cieco, vive nella strada, muore d'eroina.
il mio bambino va nelle loro scuole
ascolta le loro parole alla televisione
respira i nostri motori.
il mio bambino è pulito e ben vestito, come noi.
il futuro ha divorato il mio bambino. |
dove.
accesa la città,
spenta anche linsegna
cè aria di sapere dove andare
ma già il vestirsi non è facile
e il nostro caffè si brucia, come sempre, un poco
si esce in fretta dopo cena
non resisti con quellansia dentro che non fa stare in nessun posto
appoggiati ad una vetrina o in un bar
non sappiamo dove mettere le mani
mentre guardiamo le luci senza pace dei semafori spenti
non alziamo lo sguardo sulle voci attorno
ma con le orecchie registriamo anche il più piccolo cambio di ritmo
sarà che ci è sempre piaciuto di più aspettare che gettare le lune allo
sbaraglio
e ci si muove lenti verso unuscita
le gambe vanno da sole su per i muri
e controlliamo i gesti ma non i pensieri
questa la fatica
poi giù per me scale sui bordi
orme sempre più profonde
e in questo essere dritti e storti ci riconosciamo
stiamo nelle nostre canzoni che non ci bastano mai
anche per madri stanche
le mani stringono forte
ma nelle tasche non si trova più il caldo che sentivo alle guance nel
nostro carnevale
dove cercare con le mani cieche un gettone per chiamare
o la porta dun treno per andare o tornare. |
|
quando sono morto e rinato.
il peggiore dei
temporali si era abbattuto sulla città, verso il tramonto. dalle due del
pomeriggio tutti coloro che, per lavoro, compere o passare il tempo
saggiravano per le strade, aspettavano quel temporale. fu però più
breve del previsto ma più intenso. previsioni medie sintende: quelle
che nelluscire dai bar si potevano sentire intercalate alle frasi,
dette per dire, che si dicono nei bar pomeridiani.
lestate quasi terminata, stancamente sommava giorno dopo giorno il
riavvicinarsi di un nuovo settembre, come riprendere un discorso
interrotto da una molletta che cade da un balcone.
in fondo sembrava vita vera, lo scorrere naturale della città, quartiere
madonna di campagna. fuori da ogni ambizione turistica, dimportanza di
qualsivoglia natura, fuori anche dagli scenari decisivi del paese, in
quegli anni a metà tra il dopoguerra e la mirafiori occupata nel 69.
nemmeno si poteva dire: povertà. qualche televisione faceva mostra di sé
nei bar, tra i bicchieri di rosso, le mosche e il tuttosport. le 600
erano molte, lucide, il giro ditalia sarebbe passato vicino quellanno.
ora laria era calda del vapore che dallasfalto saliva tra le case. la
partita di pallone al campetto, interrotta dal nubifragio, non potè
ricominciare. era ora di cena. salendo le scale in tutta fretta il
frastuono delle radio inondava il palazzo, coprendo quasi la voce di mia
madre che prometteva che ora avrei sentito mio padre.
così tra una cucchiaiata e laltra, oltre la finestra il cielo che
inscuriva, nellumido fresco dellaria il gridare delle rondini a caccia
sopra i cortili svuotati dal sacro rito della cena, ecco lì mi mancò un
respiro. saltai un battito del cuore, smarrii il filo regolare dei
profili, dei nomi, dei significati.
da allora, ogni tanto, senza affannarmi, mi chiedo cosa fu. da allora,
come un involontario batter di ciglia, come un singhiozzo che passa come
arriva, quel cielo sopra la città mi segue riflesso negli occhi degli
operai stanchi sui tram, nei vetri degli ospedali, nellacqua del po
sotto le colline, immobile, come ladolescenza.
cerco quel battito perduto perché da allora ricordo più lombra degli
alberi, degli alberi. se non fosse piovuto quella sera, avrei forse
segnato un gol e ritardato la cena di quel tanto da respirare tutti i
respiri, contare il quattro dopo il tre.
comera fresca
quella serata. |
|
canzone
3 (roma).
gennaio 95
freddo nelle ossa della testa
freddo nello stomaco del cuore
stanchezza in un alloggio di roma
viene il momento che il senso dellincompiutezza
del perdersi irrisolvibile nel lavandino
di ogni goccia di tempo diventa fisicamente doloroso
penetrante come il suono di bassa intonazione
una sirena del passato tipo film bianconero anni 50
questa spossante sorda vibrazione di gong
ramifica nel cielo gelido al tramonto tra i palazzi di zona salaria
nulla per nulla di nulla di msi vince manifesti polizia polacchi pizzeria
e diventa solida la sconclusionata traiettoria di una vita vissuta
graffiata con le ginocchia sull'asfalto
dedicata a canzoni che non sono bastate né lo potevano
cari lalli e giovanni
sperduti cantori nel mio walkman
walk alone be alone be bad be dead
ora posso sfogliare svogliato l'album di mille palchi
odori di cesso
voglia di sboccare
nel grande cosmo di facce ricordate
mani strette al mattino
parole che marciscono tra i denti
saccoapelo arrotolato
e il dono lo sento nascere a poco a poco
dallo stagno inquinato dei tentativi più luccicanti
in una vita spesa a cantare qualche amore qualche bella rima
e troiate di stucco che casca tra i mille compromessi di fianco
del pavimento gelido sotto i miei piedi
stivati fuorimoda qui di fianco
e gira il mondo che è girato sempre
mentre io ascolto
il mio dono
nel porcodio più bestiale che sale dai corsi di tutta roma
ascolto
il mio dono
il silenzio, silenzio, silenzio
chiuso tra le mani che premo alle orecchie
per lasciarvi fuori
parole
melodie e automobili sul grande raccordo anulare
che girate girate girate girate girate
|
a
circa dieci anni sono stato mandato al catechismo, per prepararmi alla
cresima.
ci venne dato un
libriccino con delle illustrazioni e dei commenti, ma ricordo in modo
particolare una delle prime di quelle pagine: una coppia di persone, lui
teneva per mano un bambino e con laltro braccio si teneva vicino alla
donna, sua moglie.
di fronte a loro
avevano un campo arato, allorizzonte qualche albero, una celeste
nuvolaglia nella quale sintravvedeva una vaga silhouette. una barba,
due occhi scuri e profondi.
ai loro piedi una
sottile piantina verde con qualche fogliolina. poco più in là, un grosso
albero frondoso, dal tronco bruno.
la scritta non la
ricordo, ma il disegno suggeriva una metafora sulla vita, il nascere, il
diventare adulti e forti.
ci sono stati
giorni che guardavo le nuvole passare, dal ponte di una nave oppure
seduto lungo un torrente in alta montagna.
ho pensato che
potessero essere le stesse, stessa forma e altezza nel cielo, proprio
quelle passate quando sulla terra non cerano che oceani e vulcani e poi
sopra le barche dei fenici, di ulisse, sopra la testa di galileo o sopra
hiroshima oppure, viste dal lato opposto, da neil armstrong sullapollo.
ho cercato
anche dimmaginare le isole greche, lirlanda e la sardegna prima che
fossero raccolte le pietre per fare tutti quei muretti e liberare il
terreno per dare un po derba alle capre.
dallaereoporto di cagliari, verso norbello, lauto filava.
io guardavo
fuori, cera un sole tiepido di primo mattino e mi sentivo strano: sceso
da un aereo, caricato su una bella macchina con laria condizionata,
alla sera avevo un concerto.
il vento aveva
raccolto sparsi ciuffi di lana, grumi di lana e sterpaglia, brandelli di
giornali e buste di plastica, che ora decoravano sventolando le punte
acuminate e arrugginite del filo spinato.
i cartelli
indicavano paesi che non si vedevano mai, nascosti sulla cima di colline
brulle e deserte.
la storia di
queste due donne è rimasta impigliata nella raccolta di ritagli, foto,
canzoni che saccumula nel mio cassetto, da un sacco di tempo.
la prima: da sola
in una cascina in montagna, 1700, alto canavese. aspetta il ritorno del
suo uomo. e, tra le ombre della notte, cerca di riconoscerlo.
la seconda:
alabama, anni 50, si ritrova, sola, a volere un posto tra le donne
bianche e gli uomini bianchi e scopre che nel suo semplice gesto
sannida una storia di lotta e sofferenza di migliaia di anni e milioni
di donne e di uomini, come lei. |
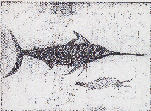
![]()